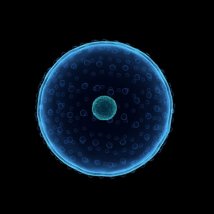I movimenti che combattono i cambiamenti climatici e i movimenti sociali anticapitalisti condividono una connessione profonda: si concentrano sulla gestione del comune. Il comune sta senza dubbio diventando il terreno centrale della lotta politica in contesti politici molto diversi. I movimenti, tuttavia, hanno una relazione differente con il comune e si concentrano anche su forme diverse dello stesso, ponendo una serie di antimonie concettuali e di sfide politiche. L'incontro di movimenti attorno al summit delle Nazioni Unite sul clima a Copenhagen (dicembre 2009) è stata una prima opportunità per affrontare chiaramente e intraprendere queste sfide.
Le principali differenze tra movimenti e, al contempo, le antinomie che in un certo senso si frappongono partono dal fatto che si concentrano su forme distinte di comune, con qualità differenti. Per i movimenti che operano sul terreno dei cambiamenti climatici e per i movimenti ecologisti in generale, il comune si rifà principalmente alla terra e ai suoi ecosistemi, atmosfera inclusa, i fiumi e gli oceani, le foreste e le forme di vita che vi afferiscono. I movimenti sociali anticapitalisti invece danno del comune un'altra definizione e cioè il comune è il prodotto del lavoro umano e della creatività che condividiamo, come le idee, le conoscenze, le immagini, i codici, gli affetti, le relazioni sociali. Questi beni comuni sono sempre più centrali nella produzione capitalista - un fatto questo che produce una serie di conseguenze importanti nei tentativi di mantenere o riformare il sistema capitalistico e nei progetti di resistenza e sovvertimento di questo sistema. Come prima approssimazione, questi due ambiti potrebbero essere definiti il comune ecologico e il comune social-economico o il comune naturale e il comune artificiale, per quanto entrambe queste categorie si dimostrano fin da subito insufficienti.
In ogni caso, ci sono almeno due aspetti essenziali in cui i due ambiti del comune sembrano essere mossi da logiche antitetiche. Innanzitutto, se molto del comune ecologico è caratterizzato dalla propensione alla conservazione – si mettono in luce i limiti della terra e delle forme di vita che interagiscono con essa - sul fronte invece del sociale o delle forme artificiali del comune l’ambito di discussione generalmente è incentrato sulla creazione e sulla natura aperta e illimitata della produzione del comune. Secondariamente, il sociale pone, in generale, come centrali gli interessi dell’umanità mentre l’ambientale genera una sfera di interessi ben più ampia dell’umano o dell’animale. Il mio sospetto è che queste opposizioni apparenti si riveleranno, grazie all’approfondimento, potenziali complementarietà piuttosto che relazioni contradditorie tra accezioni del comune e, allo stesso tempo, tra le forme di azione politica richieste da ciascun ambito specifico. Ciò che mi auguro di evidenziare, nello svolgimento della trattazione, è il bisogno di dialogo sui due ambiti del comune, sulle loro qualità e sulle relazioni potenziali tra di loro.
Prima di approfondire queste differenze, e le sfide che presentano, voglio però soffermarmi brevemente sulle connessioni potenziali ed esistenti tra movimenti per il comune. In molti, ma non in tutti gli aspetti, le due accezioni del comune funzionano secondo un'identica logica, e questo è alla base del profondo collegamento tra i diversi movimenti. Entrambe le forme del comune, ad esempio, sfuggono e sono deteriorate dalle relazioni di proprietà. Inoltre, e forse questo è corollario a quanto appena affermato, il comune in entrambe le sue accezioni supera le tradizionali misure di valore economico e impone piuttosto il valore della vita quale unico criterio valido di valutazione. E a questo punto le distinzioni tra l'ecologico e il sociale sfumano da questo punto di vista biopolitico.
Per dare avvio alla discussione teoretica bisogna dunque stabilire la centralità del comune. La riflessione sulla centralità del comune è molto più avanzata e vasta nel pensiero ecologista. In termini generali, non solo noi beneficiamo dell’interazione con la terra, il sole e gli oceani ma il loro deperimento ha anche effetti su di noi. L’inquinamento di aria e acqua non sono confinati nel luogo specifico della loro produzione, ovviamente, e non si limitano a confini nazionali. E, allo stesso modo, il cambiamento climatico ha effetti sull’intero pianeta. Non è come dire che questi cambiamenti hanno gli stessi effetti su tutti: la crescita del livello degli oceani, ad esempio, avrà un impatto più immediato su chi vive in Bangladesh che su chi vive in Bolivia. Il comune tuttavia è il fondamento che sta alla base del pensiero ecologista, di fronte al quale emergono le peculiarità specifiche di ogni luogo.
Nel pensiero sociale ed economico, invece, la centralità del comune non è riconosciuta estensivamente. L’affermazione della sua centralità si fonda sull’ipotesi che siamo nel mezzo di un passaggio epocale da un capitalismo economico centrato sulla produzione industriale ad uno centrato su ciò che possiamo chiamare produzione immateriale o biopolitica. Io e Toni Negri abbiamo argomentato quest’ipotesi in tre volumi – Impero, Moltitudine, Comune. Qui di seguito ne propongo una breve sintesi. La prima parte dell’affermazione è semplice: nei due secoli passati l’economia capitalista si è incentrata sulla produzione industriale. Che, sia ben chiaro, non vuole dire che tutti i lavoratori durante questo periodo siano stati nelle fabbriche, cosa che infatti non corrisponde alla realtà. E’ tuttavia indubbio che gli impiegati nell’industria piuttosto che nei campi o a domicilio sono stati determinanti nella divisione geografica, razziale e di genere del lavoro. La produzione industriale è stata centrale poiché le qualità dell’industria – le sue forme di meccanizzazione, gli orari di lavoro, le relazioni salariali, i suoi regimi di disciplina del tempo e della precisione, e così via – sono state progressivamente imposte agli altri settori della produzione e della vita sociale nel loro insieme, creando così non solo un’economia industriale, ma anche una società industriale.
Anche la seconda parte dell’affermazione non presenta controversie e cioè, la produzione industriale non ha più una posizione di centralità nell’economia capitalista. Non significa però che meno persone lavorino in fabbrica oggi, ma che l’industria non definisce più la posizione gerarchica nelle varie divisioni del lavoro e, più significativamente, significa che le qualità dell’industria non sono più imposte a altri settori e alla società.
L’ultimo elemento dell’ipotesi è tuttavia più complesso e richiede quindi un’argomentazione più estesa e approfondita. In breve, al posto dell’industria oggi sta emergendo come centrale la produzione di beni immateriali o beni con una significativa componente immateriale, come le idee, i saperi, le lingue, le immagini, i codici e gli affetti. Occupazioni coinvolte nella produzione immateriale attraversano l’economia dall’alto al basso, dagli operatori sociosanitari agli educatori ai dipendenti dei fast food, dei call center, alle hostess. Di nuovo, questa non è un’affermazione quantitativa ma qualitativa, ossia sulle qualità che progressivamente sono imposte sui settori dell’economia e della società nel suo insieme. In altre parole, gli strumenti cognitivi e affettivi della produzione immateriale (che tendono a distruggere le strutture del giorno lavorativo e ad offuscare la tradizionale divisione tra tempo lavorativo e non lavorativo), insieme ad altre sue qualità, si stanno generalizzando.
Questa forma di produzione dovrebbe essere intesa come biopolitica, dato che le relazioni sociali e le forme di vita sono alla fine l’oggetto stesso della produzione. In questo contesto, le divisioni economiche tradizionali tra produzione e riproduzione tendono a svanire. Le forme di vita sono prodotte e riprodotte simultaneamente. Qui si inizia a vedere la prossimità tra la nozione di produzione biopolitica e pensiero ecologico, poiché entrambi si incentrano sulla produzione/riproduzione di forme di vita, con l’importante differenza che la prospettiva ecologica estende la nozione di forme di vita molto oltre i limiti dell’umano e dell’animale (su questo tornerò successivamente).
L’ipotesi che la produzione immateriale o biopolitica stia emergendo come dominante può anche essere affrontata nei termini di cambiamenti storici nella gerarchia delle forme di proprietà. Prima che l’industria occupasse una posizione centrale nell’economia, fino all’inizio del Diciannovesimo secolo, la proprietà immobile, come la terra, aveva una posizione dominante rispetto alle altre forme di proprietà. Nel lungo periodo della centralità dell’industria tuttavia la proprietà mobile, come le merci, finirono per prevalere sulla proprietà immobile. Certo, brevetti, diritti d’autore, e altri metodi per regolare e mantenere il controllo esclusivo della proprietà immateriale, sono soggetti di vivacissimi dibattiti nell’ambito della legge sulla proprietà. La crescente importanza della proprietà immateriale può funzionare come evidenza, o quanto meno indice, della centralità emergente della produzione immateriale.
Mentre nel precedente periodo di transizione, il concorso tra forme dominanti di proprietà si giocò sulla questione della mobilità (terra immobile contro merci mobili), oggi la competizione si incentra su esclusività e riproducibilità. La proprietà privata nella forma di barre d’acciaio, automobili e televisioni obbedisce alla logica della scarsità: se tu li usi, io non posso. La proprietà immateriale come idee, lingue, saperi, codici, musica e affetti, di contro, può essere riprodotta in modo illimitato. Infatti, molti di questi prodotti immateriali funzionano solamente nel pieno delle loro potenzialità quando sono apertamente condivisi. L’utilità individuale di un’idea o di un affetto non è ridotta dalla sua condivisione. Al contrario, diventano utili solo nell’essere messi in comune.
Questo è il significato di quanto affermato in principio che il comune sta diventando centrale nell’economia capitalista contemporanea. Innanzitutto, la forma di produzione emergente nella posizione dominante deriva generalmente da beni immateriali o biopolitici che tendono a essere comuni. La loro natura è sociale e riproducibile dato che è sempre più difficile mantenere un controllo esclusivo su di essi. In secondo luogo, probabilmente il più importante, la produttività di tali beni nello sviluppo economico futuro dipende dal loro essere comune. La privatizzazione di idee e saperi impedisce la produzione di nuove idee e saperi, così come linguaggi privati e affetti privati sono sterili e inutili. Se la nostra ipotesi è corretta, allora il capitale paradossalmente fa sempre di più affidamento sul comune.
Questo porta alla prima, logica, caratteristica condivisa dal comune in entrambe le sue accezioni, ecologico e sociale. Entrambi sfidano e sono deteriorati dalle relazioni di proprietà. Nell’ambito sociale ed economico, non solo è difficile mantenere con il controllo diritti esclusivi sulla produttività immateriale e, come già detto, privatizzare i beni biopolitici ne diminuisce la loro produttività futura. Qui emerge una potente contraddizione nel cuore della produzione capitalistica tra il bisogno del comune nell’interesse della produttività e il bisogno di privato nell’interesse dell’accumulazione capitalistica. Questa contraddizione può essere letta come una nuova versione dell’opposizione classica, spesso citata nel pensiero marxista e comunista, tra la socializzazione della produzione e la natura privata dell’accumulazione. Le lotte contro la cosiddetta bio-pirateria in Brasile e altrove sono un teatro contemporaneo di questo scontro. Saperi indigeni e proprietà medicinali di certe piante amazzoniche, ad esempio, sono brevettate da multinazionali internazionali e diventano proprietà privata, e i risultati di questo non sono solo ingiusti ma anche distruttivi. (Vorrei però precisare che sono contrario alla definizione di “pirateria”: storicamente i pirati almeno avevano la dignità di rubare proprietà private, mentre queste multinazionali rubano il comune e lo trasformano in proprietà privata).
Nell’argomentazione ecologista del comune, è parimenti chiaro come il comune sfidi e sia deteriorato dalle relazioni proprietarie. In primis, sfida la proprietà semplicemente perchè gli effetti di beneficio e o di danno all’ambiente eccedono sempre i limiti della proprietà come lo fanno con i confini nazionali. Significa cioè che come la tua terra condivide con la terra del vicino i benefici di sole e pioggia, allo stesso modo condivide anche gli effetti distruttivi di inquinamento e cambiamento climatico. Le strategie del neoliberalismo hanno chiaramente puntato alla privatizzazione del pubblico - trasporti, servizi, industrie e, insieme, alla privatizzazione del comune (ad esempio, petrolio in Uganda, diamanti nella Sierra Leone, litio in Bolivia e addirittura le informazioni genetiche della popolazione dell’Islanda). Il deterioramento del comune da parte della proprietà privata suggerisce ancora una volta una relazione contraddittoria, la natura privata dell’accumulazione (attraverso i profitti di un’industria inquinante, ad esempio) confligge con la natura sociale dei danni che ne risultano. Mettendo le due formulae insieme si può vedere la contraddizione con il comune su entrambi i lati, per così dire, della proprietà privata: la natura sempre più comune della produzione entra in conflitto con il comune, con la natura sociale degli effetti del suo detrimento.
Numerose e potenti battaglie sono nate nelle ultime decadi per combattere la privatizzazione neoliberista del comune. Una battaglia di successo che illustra parte della mia argomentazione è quella dell’acqua a Cochabamba, in Bolivia nell’anno 2000. Questa, insieme alla guerra sul gas che ebbe il suo picco nel 2003 a El Alto, ha contribuito nel 2005 all’elezione di Evo Morales. La situazione all’epoca precipitò per un classico accordo neoliberista. Il Fondo monetario internazionale fece pressione sul governo boliviano perché privatizzasse il sistema dell’acqua. Il principio era che rispetto al costo di trasporto dell’acqua pulita era più conveniente che i destinatari se la pagassero. Il governo vendette dunque il sistema idrico a un consorzio di multinazionali straniere, che subito «razionalizzarono» il prezzo dell’acqua, aumentandolo significativamente. Le successive proteste per la de-privatizzazione dell’acqua si intersecarono con una serie di altri tentativi di mantenere il controllo sul comune, ossia sulle risorse naturali, sulle forme di vita delle comunità indigene e sulle pratiche sociali dei contadini e dei poveri. Oggi, i disastri delle privatizzazioni neoliberiste sono sotto l’occhio di tutti e dunque il tentativo di scoprire metodi alternativi di gestione e promozione del comune è sempre più essenziale e urgente.
Un’altra logica caratteristica condivisa dal comune nelle sue due accezioni, più astratta ma non per questo meno significativa, è che il comune rompe ed eccede le misure dominanti del valore. Gli economisti contemporanei fanno i salti mortali per misurare il valore dei prodotti biopolitici come le idee e gli affetti. Spesso li categorizzano come «esternalità» che sfuggono agli schemi standardizzati di misurazione. I commercialisti combattono allo stesso modo con i cosiddetti «beni intangibili», il cui valore appare quasi esoterico. Infatti, il valore di un’idea, di una relazione sociale, o di una forma di vita, eccede il valore che la razionalità capitalista può imprimere loro, non perché la quantità sia sempre maggiore, ma piuttosto perché non è incasellabile nel sistema stesso di misurazione. (La finanzia, ovviamente, gioca un ruolo centrale nella valutazione dei beni e della produzione biopolitici e l’attuale crisi economico-finanziaria deriva in gran parte, a mio avviso, dall’instabilità della misura capitalistica nell’afferrare le nuove forme dominanti di produzione. Si tratta di una discussione complessa che purtroppo devo rimandare a un’altra occasione). Uno dei personaggi principali del dickensiano Tempi difficili è il proprietario della fabbrica, Thomas Gradgrind. Lui è convinto di poter razionalizzare la vita sottomettendone tutte le sfaccettature alla misura economica, «affari di cuore» (come la sua relazione con i bambini) compresi. Il lettore però rapidamente intuisce che Gradgrind imparerà presto che la vita eccede i limiti di qualsiasi misurazione. Oggi persino il valore dei beni economici e dell’attività, visto che il comune è sempre più centrale alla produzione capitalistica, eccedono e sfuggono alle misure tradizionali.
Nell’accezione ecologica anche il valore del comune è incommensurabile o, quantomeno, non obbedisce alle misurazioni capitalistiche tradizionali del valore economico. Ciò non vuol dire che qualsiasi misurazione scientifica, come le proporzioni di anidride carbonica o di gas metano nell’atmosfera, non sia essenziale o centrale. E’ ovvio che lo sia. La mia argomentazione piuttosto vuol significare che il valore del comune sfida la misurazione stessa. Prendiamo, come controesempio, le posizioni - iper-pubblicizzate - di Bjørn Lomborg contro la lotta al surriscaldamento globale. Come nel caso di Gradgrind, la strategia di Lomborg è la razionalizzazione della questione attraverso il calcolo dei valori coinvolti per definire le priorità. Distruzione stimata e costo per prevenirla renderebbero inutile il tentativo per Lomborg. Ossia, - asserisce Lomborg con una logica apparentemente impeccabile - il valore stimato della distruzione quale conseguenza del surriscaldamento globale non vale i costi della lotta per arginare il fenomeno. Il problema tuttavia è che non si può misurare il valore delle forme di vita che sono distrutte. Quanti dollari dovremmo assegnare al fatto che mezzo Bangladesh rischia di sprofondare sott’acqua? O alla siccità permanente dell’Etiopia? O ancora alla devastazione della quotidianità di vita degli Inuit? La sola proposizione di queste domande risveglia la stessa nausea e l’indignazione che si provano nel leggere le schede delle compagnie assicurative che calcolano l’ammontare dei rimborsi per un dito perso o il valore di un occhio o un braccio.
L’incapacità di afferrare il valore del comune nell’ambito delle tradizionali misure capitalistiche dà l’opportunità di vagliare proposte quali quella sul commercio del carbone largamente discusse nell'ufficialità di Copenhagen. Gli accordi sul commercio del carbone implicano generalmente limitazioni nella produzione di anidride carbonica e di altri gas serra, in modo da limitare il mercato, così ché le produzioni di questi gas possano assumere un determinato valore economico e quindi essere commercializzate. Questi schemi non pretendono però di misurare direttamente il valore del comune, ma invece di farlo indirettamente, monetarizzando la produzione di gas che danneggiano e corrompono il comune. Ci si dovrebbe tuttavia ricordare che assegnare valori determinati a beni incommensurabili e assumere che il mercato creerà razionalmente un sistema stabile e benefico, in molte occasioni ha portato in realtà a disastri - ad esempio, l’attuale crisi finanziaria. Inoltre, va tenuto in considerazione che le modalità con cui certe logiche proprietarie e di mercato non diminuiranno, ma probabilmente esaspereranno le gerarchie sociali che, su scala globale, sono contrassegnate da povertà e esclusione. In ogni caso, dovrebbe essere chiaro che le proposte che si fondano sulle misure capitalistiche del valore e sulla razionalità del mercato non possono afferrare il valore del comune, né tanto meno riescono ad occuparsi del problema del cambiamento climatico andando al cuore del problema, e neppure indirettamente. Le forme di vita non sono misurabili o, forse, obbediscono a una scala di valori radicalmente differente e che si basa, appunto, sul valore della vita, che nessuno è stato in grado ancora di stabilire - almeno a me sembra (o che forse abbiamo perso).
Il mio punto di partenza, e arrivo, primario è che come le differenti forme del comune si ribellano alle relazioni proprietarie, allo stesso tempo sconfiggono le misurazioni tradizionali della razionalità capitalistica. Questo due logiche condivise sono una base significativa, almeno per me, per capire entrambe le accezioni del comune e per lottare per preservarle e farle crescere. Condividere le qualità del comune, sotto i due aspetti analizzati finora, dovrebbe costituire le fondamenta per il collegamento di forme di attivismo politico che puntano all’autonomia e alla gestione democratica del comune.
Esistono tuttavia due aspetti importanti in cui le battaglie per il comune operano con logiche opposte, a seconda dell’accezione del comune stesso. L'antinomia centrale, da cui altre poi si dipartono, ha a che fare con la scarsità e con i limiti. Il pensiero ecologista necessariamente si incentra sulla finitezza della terra e dei suoi sistemi. Il comune può supportare un certo numero di persone, ad esempio, e pur tuttavia può essere ancora riprodotto. La terra, i suoi spazi ancora naturali, devono essere difesi dai danni dello sviluppo economico e da altre attività umane. Il discorso scientifico sui cambiamenti climatici è costellato da indicazioni di limiti e punti di svolta irreversibili, ad esempio a proposito di quanto accadrà se continueranno ad esserci più di 350 parti per milione di andride carbonica nell’atmosfera. Una politica del comune sotto il profilo economico e sociale, di contro, generalmente enfatizza il carattere illimitato della produzione. La produzione di forme di vita, idee, affetti inclusi, non ha alcun limite prefissato. Ciò non significa, ovviamente, che più idee ci sono meglio è, ma invece che non operano in una logica di limitatezza o scarsità. La proliferazione di idee non le degrada, né la loro condivisione con gli altri. Si sviluppa quindi la tendenza, nella lettura ecologista del comune, a lanciare appelli per preservare e limitare. Al contrario, il socio-economico è caratterizzato dalla celebrazione dell’illimitatezza della potenzialità creativa.
Il conflitto concettuale tra limitato ed illimitato si riflette negli slogan, apparentemente incompatibili, dei movimenti. Uno degli slogan più diffusi degli anticapitalisti è «vogliamo tutto per tutti». Per chi ha invece una coscienza ecologica dei limiti questo ha dell'assurdo, è una nozione irresponsabile che ci porterà sempre di più nella china dell'autodistruzione. Al contrario, «non c'è alcun piano B» è stato un vessillo delle manifestazioni di Copenhagen. Per gli attivisti anticapitalisti questo slogan richiama troppo da vicino lo slogan neolibesista che spopolò trent'anni fa sotto Margaret Thatcher: «Non c'è alcuna alternativa». E, non c'è dubbio, le lotte contro il neoliberalismo degli ultimi decenni sono state segnate dal credere nella possibilità di alternative radicali, apparentemente illimitate. In sintesi, lo slogan del Forum sociale mondiale «Un altro mondo è possibile» si potrebbe tradurre, nell'ambito dei movimenti che si occupano di cambiamenti climatici, in qualcosa del tipo «Questo mondo è ancora possibile, forse».
In termini semplicistici, anche troppo semplicistici, si potrebbe dire che il pensiero ecologista è contro lo sviluppo ed è per porre paletti sulla strada dello sviluppo economico, mentre gli attivisti dell’accezione economica e sociale del comune sono decisamente promotori dello sviluppo. Certo questa sarebbe una semplificazione estrema. La parola “sviluppo” nei due casi ha infatti significati profondamente diversi. Il tipo di sviluppo della produzione sociale del comune si differenzia sostanzialmente da quello dello sviluppo industriale. Una volta che noi riconosciamo, come detto sopra, che nel contesto biopolitico le divisioni tradizionali tra produzione e riproduzione si infrangono, è più facile comprendere che le chiamate alla difesa e quelle alla creazione non sono davvero in contrapposizione bensì sono complementari. Entrambe le prospettive si riferiscono alla produzione/riproduzione delle forme di vita.
Un secondo elemento di conflitto nelle battaglie per il comune ha a che fare con il fatto che gli interessi dell’umanità fungono da cornice di riferimento. Le lotte per il comune nell’accezione economico-sociale si basano generalmente sull’umanità e senz’ombra di dubbio uno dei compiti più importanti è estendere a tutta l’umanità la politica di superamento delle gerarchie, dell’esclusione di classe e proprietà, di genere e sessualità, razza e etnia, eccetera. Nelle battaglie per il comune nell’accezione ecologista invece la cornice di riferimento va al di là dell’umanità. Che è considerata nella sua interazione e cura delle altre forme di vita e dell’ecosistema, anche nelle situazioni in cui la priorità è assegnata agli interessi dell’umanità. E in molti contesti di radicalismo ecologista, gli interessi delle forme di vita non umane hanno lo stesso, o anche maggiore, peso di quelli dell’umanità.
Questa è una differenza, a mio avviso, sostanziale di prospettiva nel comune. In ogni caso, non è una differenza insuperabile o distruttiva. Ritengo che chi si occupa di ambiente sarebbe beneficiato da un confronto maggiore sulla natura delle gerarchie sociali e sui modi di contrastarle nell’attivismo e nella teoria. Allo stesso tempo, chi si occupa di battaglie sociali trarrebbe vantaggio nell’approfondire la questione dei limiti della terra e delle forme di vita, visto che interagiscono con l’umanità ed hanno un’esistenza propria.
Spero, con questo intervento, di aver articolato il concetto secondo il quale il comune serve a definire alcune delle questioni fondamentali che oggi la politica si trova a affrontare nell’ambito di due sfere del comune. (Lascio ad altre occasioni lo studio della natura del comune sotto altre accezioni quale l’identità o le istituzioni sociali come famiglia e nazione). Oggi, lottare per il comune e inventarne nuove modalità di gestione è fondamentale in qualsiasi progetto di reimmaginazione della società. Le divergenze tra lotte, orientate su aspetti differenti del comune, hanno bisogno di essere articolate e negoziate ma queste diversità sono salutari per me e assumerle non può che farci andare avanti e crescere. Per questo, ho deciso di seguire le discussioni preparatorie e gli sforzi organizzativi delle azioni che si sono svolte in occasione della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite, di cui ho accennato più sopra. Si tratta di mobilitazioni che mettono insieme ambientalisti, movimenti anticapitalisti e altri movimenti sociali. Discussioni e confronti su queste tematiche sono spesso produttive e portano, attraverso forme pratiche e teoriche di ricerca collettiva tra attivisti dei movimenti, generalmente a una crescita. Non vedo l’ora di vederne gli sviluppi.
Molte divergenze di strategia politica, ed è ciò che potremmo definire antinomie politiche, derivano dall'antinomia concettuale tra limitato e illimitato. La prima potrebbe essere chiamata l'antinomia della governance tra autonomia e intervento dello Stato. Un obiettivo centrale dei movimenti sociali anticapitalisti e anti-neoliberisti è la promozione di forme di autonomia e autogoverno quali mezzi per sfidare e distruggere le gerarchie sociali. Le comunità zapatiste hanno fornito un esempio potente, hanno mostrato che si può sviluppare un proprio potere nel governo di se stessi, attraverso la sperimentazione di forme democratiche di governance. Nell'ambito dei movimenti sul cambiamento climatico, al contrario, la strategia politica si focalizza generalmente meno sull’autonomia che sulla necessità di imporre agli Stati di agire. Questo è in parte dovuto alla natura globale del problema. Le comunità autonome possono anche ridurre i propri livelli di produzione di anidride carbonica, ad esempio, ma questo avrà pochi effetti sui cambiamenti climatici se i maggiori inquinatori non vengono fermati. Gli Stati sembrano essere gli unici attori capaci di arrivare a tanto, insieme forse alle principali imprese e istituzioni sovranazionali come le Nazioni Unite. L’appello agli Stati sul riscaldamento globale è legato anche all'urgenza del problema. Sembra esserci poco tempo per la sperimentazione o per interventi parziali, prima che sia troppo tardi per intervenire contro i fattori critici che provocano i cambiamenti climatici. Questa antinomia politica, senza ombra di dubbio, non è assoluta. I movimenti autonomi si sono sempre rivolti agli Stati: in alcuni casi per sfidarne il controllo, in altri per cooperare con governi progressisti. Di contro, molti movimenti che operano in ambiente ecologico considerano l'autonomia un principio che fa persino parte della loro strategia. Ciononostante, permane una differenza significativa nelle priorità.
Un'altra antinomia politica ha a che fare con la questione del sapere. I progetti di autonomia e autogoverno, tanto quanto le lotte contro le gerarchie sociali, agiscono sulla base dell'assunto che ognuno ha accesso al sapere necessario all'azione politica. Gli operai in fabbrica, i neri in una società “bianca”, le donne in una società patriarcale possiedono quelle esperienze quotidiane di subordinazione che sono il seme della ribellione. Una lunga pratica è richiesta per la trasformazione di questa indignazione in progetto politico, ma l'assunto è che tutti abbiamo accesso alle conoscenze di base necessarie. A me questo ricorda l'assunzione fondamentale del «De Intellectus emendatione» di Spinoza e cioè «habemus enim ideam veram», ossia abbiamo un'idea vera o, meglio, abbiamo almeno un'idea vera che costituisce le fondamenta sui cui successivamente possiamo costruire e realizzare un intero edificio di sapere. L'assunto di un’accessibilità generale all'esperienza e alla conoscenza della subordinazione ha un ruolo altrettanto fondativo. Se questo sapere di base non fosse aperto a tutti, i progetti democratici e orizzontali di autonomia e autogoverno sarebbero impensabili. La relazione con il sapere dei movimenti ecologisti è decisamente diversa. C'è ovviamente un progetto di educazione pubblica sui cambiamenti climatici e le esperienze individuali in materia sono spesso invocate. Ma l'esperienza individuale è inaffidabile. Gli inverni sono più rigidi in un'area o in un dato anno e più miti in un'altra; le piogge possono aumentare in un luogo e diminuire in un altro. Nessuna di queste esperienze sono basi adeguate nella comprensione dei cambiamenti climatici. Una volta che uno di noi sperimenta gli effetti dei cambiamenti climatici in maniera verificabile sarà infatti troppo tardi per fermarne le conseguenze. I semplici fatti - ad esempio, l'aumento di proporzione di Co2 nell'atmosfera e i suoi effetti - sono altamente scientifici e si astraggono dal nostro esperire quotidiano. I progetti di pedagogia pubblica possono aiutare a divulgare quel dato sapere scientifico ma, in contrasto con il sapere basato sull'esperienza della subordinazione, questo è fondamentalmente un sapere da esperti.
Una terza antinomia politica, che è forse quella determinante, segna la distanza tra due temporalità. Anche se è vero che i movimenti anticapitalistici e anti-neoliberisti usano sempre una retorica di urgenza - insistendo, ad esempio, che le loro richieste ottengano risposte adesso - la temporalità della formazione di comunità autonome e della loro organizzazione democratica è costituente. Il tempo è cioè determinato dallo stesso processo organizzativo. L'urgenza della richiesta è davvero secondaria rispetto alla sua temporalità costituente. Al contrario, l'urgenza è la temporalità principale delle politiche dei cambiamenti climatici. A breve sarà troppo tardi per salvare il pianeta e forse lo è di già. Quest'urgenza enfatizza o esacerba la separazione tra le prime due antinomie politiche. Se non c'è più tempo allora non possiamo aspettare lo svilupparsi di un sapere generalizzato o la crescita di comunità autonome. Dobbiamo agire ora con gli esperti e i poteri dati.
L'antinomia della temporalità definisce i due movimenti come due facce dell'apocalisse. I movimenti anticapitalisti sono apocalittici nella lunga tradizione dei gruppi millenaristi e rivoluzionari che lottano per accelerare eventi di trasformazione radicale. La fine dei giorni è l'inizio di un nuovo mondo. L'immaginario apocalittico degli ecologisti, al contrario, vede il cambiamento radicale come una catastrofe. Il cambiamento del clima terrestre diminuirà significativamente, o addirittura distruggerà le forme di vita esistenti. La fine dei giorni è semplicemente la fine.
Ritengo sia utile riconoscere la profondità di queste antinomie per capire la sfida che ci aspetta. Non intendo affatto suggerire che queste differenze rendano l’incontro tra movimenti anticapitalistici e movimenti sul cambiamento climatico impossibile. Ricordiamoci che dieci anni fa, al tempo delle proteste contro il WTO di Seattle, ci siamo trovati di fronte a una simile antinomia politica, quella tra la globalizzazione e l'anti-globalizzazione. I manifestanti si dichiararono contro le forme di globalizzazione correnti, ma non accettarono l'etichetta «anti-globalizzazione» appiccicata loro dai media. Ci è voluto tempo e molto sforzo collettivo per sviluppare un concetto e pratiche di altra-globalizzazione che facessero scomparire quest'antinomia. Ed è quindi compito dei movimenti afferrare queste antinomie, lavorarci, digerirle e creare un nuovo contesto concettuale e di pratica. Ed anche se rimane ancora molta strada da percorrere, questo lavoro a Copenhagen è già iniziato.